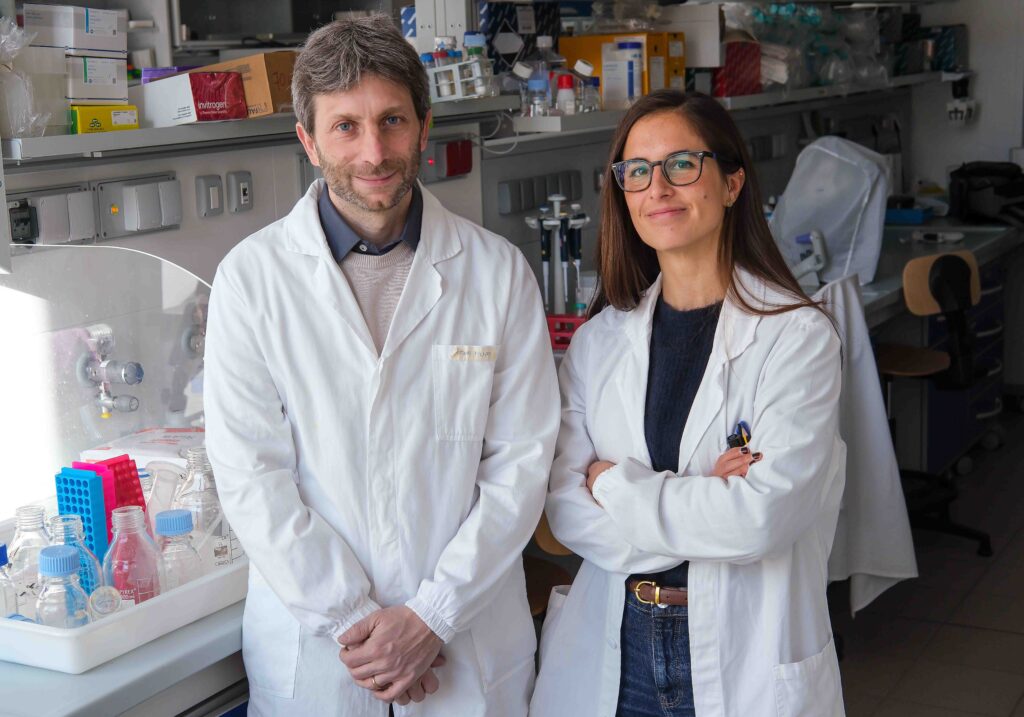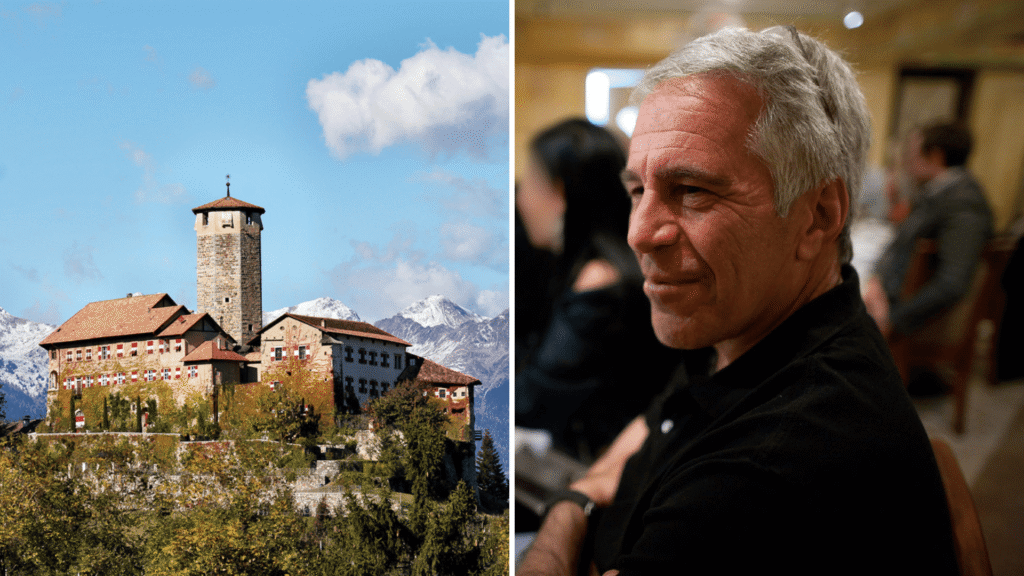L'intervista
mercoledì 15 Novembre, 2023
Carlotta Vagnoli e le cronache (sbagliate) dei femminicidi: «Tra favole e mostri, quanta pornografia del dolore»
di Claudia Gelmi
La ricercatrice presenterà sabato a Riva del Garda il suo libro «Poverine. Come non si racconta un femminicidio»: «Abbiamo delle linee guida in Italia, ma permane un problema nei media nel parlare di violenza contro le donne»

«Secondo lei è stato un femminicidio?» è il titolo di un articolo di Giulia Siviero uscito sul «Post» nel 2018 che dice, attraverso una serie di interviste fatte in loco a rappresentanti della piccola comunità di Tenno, della resistenza nel comprendere in primis e conseguentemente nell’usare le giuste parole per definirla, l’uccisione nel 2017 di Alba Chiara Baroni per mano (armata) di Mattia Stanga come ciò che a tutti gli effetti è stata, ovvero un femminicidio. L’articolo, che nel 2019 vinse anche il «Diversity Media Award», racconta di quanto una consistente parte della comunità – compresi diversi esponenti politici non esclusi quelli di genere femminile – abbia manifestato una confusa e atavica riluttanza nel dare il giusto nome a un’azione inequivocabile.
Nasce dal «trauma» provocato dalle parole usate, non usate, abusate, anche da parte dei media, nelle cronache di quei drammatici e divisivi mesi, la volontà da parte dell’associazione Alba Chiara – nell’ambito del festival «Eutropia» che coinvolge una fitta rete di realtà altogardesane – di organizzare l’incontro che sabato prossimo alle 21 al Conservatorio di Riva del Garda vedrà Carlotta Vagnoli presentare il suo libro «Poverine. Come non si racconta un femminicidio» (Einaudi, 2021). Autrice e attivista femminista, Vagnoli è molto seguita sui social, che utilizza come veicoli di divulgazione su temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere e gli stereotipi.
Partendo dalla premessa che sta a cuore alle associazioni di «Eutropia» e che ha a che fare con la domanda di Siviero in incipit «Secondo lei è stato un femminicidio?», Vagnoli – moderata dalla collaboratrice del «T» Stefania Santoni, consulente culturale esperta in questioni di genere – spiegherà come nella narrazione giornalistica la vittima di femminicidio non occupi quasi mai una posizione centrale, ma rimanga un personaggio secondario anche quando la propria morte è al centro della storia, e come questo modello assolva retoricamente il carnefice, giustificando la violenza talvolta fin dai titoli degli articoli che ancora troppo spesso tendono a occultare i meccanismi della società patriarcale.
«Ogni volta in cui le donne vengono ammazzate la reazione unanime è sempre quella di un composto, sommesso, quasi imbarazzato: “poverina”», scrive l’autrice toscana, che qui risponde ad alcune domande, partendo da quella che dà il titolo al suo breve saggio.
Vagnoli, come non si racconta un femminicidio? In altre parole, come si può scrivere di femminicidio senza alimentare radicati stereotipi e culture che afferiscono alla mentalità patriarcale e che hanno il devastante potere di uccidere, con la parola e la penna, la vittima per la seconda volta?
«Abbiamo delle linee guida in Italia, il “Manifesto di Venezia” ne è un esempio (presenta le buone pratiche per giornalisti e giornaliste per il rispetto e la parità di genere nell’informazione e per una corretta informazione contro la violenza sulle donne, ndr), ma nonostante questo permane un problema nel parlare di femminicidio e violenza contro le donne. Innanzitutto si tende a rendere protagonista l’uomo che agisce violenza, mentre la donna spesso viene presentata solo con il suo nome, sminuita nella sua dignità anche da morta. Poi c’è l’accostamento aberrante delle immagini della coppia nei loro momenti felici e l’uso di parole assolutamente fuorvianti. Persiste una forte resistenza nelle redazioni e inizio a pensare che si tratti di scelte precise: i titoli portano click e i click portano soldi. Persiste anche una morbosità che appassiona e che frutta tantissimo. C’è un forte bisogno di cambiamento dall’interno, di formazione, di presa di consapevolezza. Un esempio positivo è quello de “La Stampa”, che si è dotata di un “diversity editor”, il quale ha il compito di favorire un’equa e inclusiva rappresentazione nell’uso del linguaggio giornalistico».
Ci fa un esempio di queste parole da lei definite «fuorvianti»?
«Il “gigante buono”, come nel femminicidio di Elisa Pomarelli (del 2019, ndr), “amore non corrisposto”, “raptus di follia”: in generale tutte le espressioni che tendono a romanticizzare e che allontanano dal movente che ha a che fare invece con la cultura del possesso e con la finalità di cancellare, annientare la vita della donna».
Il problema che hanno i media con la narrazione della violenza è ben noto a chi ne analizza i linguaggi. Lei usa termini come «favolizzazione», «romanticizzazione» di fatti che sono semplicemente brutali e troppo spesso preannunciati. Quanto è pericoloso e fuorviante sostituire il concetto di «delitto culturale» con quello di «delitto passionale»?
«Sia la romanticizzazione che la narrazione del femminicida come un mostro, rendono unici e lontani da noi questi fatti, come se non fossero invece parte di una cultura e di una catena del sistema. Non si tratta di una serie di sfortunati eventi, ma dell’esito di una cultura violenta. Siamo nell’antitesi, per cui il delitto di matrice culturale viene fatto passare come delitto passionale. Quando si parla in termini di favole, sembra che questi fatti non ci tocchino perché tendiamo a credere che i mostri vivano solo nelle favole. Releghiamo il male, lo allontaniamo nella dimensione del fantastico, così non ci riguarda. La favolizzazione serve a rassicurarci che quelle cose non succederanno a noi. La cultura sessista e patriarcale non ha invece nulla a che vedere né con i mostri né con l’“eccesso di amore”».
La cultura dello stupro, fortemente costitutiva delle nostre società fin dagli albori della storia, volenti o nolenti l’abbiamo interiorizzata tutti e tutte. Il percorso di presa di coscienza e comprensione di essere fatti e fatte anche di questa sovrastruttura richiede la possibilità di venire in possesso degli strumenti per riconoscerla. Lei lavora molto con i giovani e con le scuole. Quanto è importante questa mediazione?
«È fondamentale. Spesso si dice che sarebbe compito delle famiglie spiegare le cose ai figli. Ma non tutte le famiglie sono preparate allo stesso modo. Io credo che la cultura, per essere davvero democratica e arrivare a tutti e tutte, si debba fare nei luoghi della cultura, e quindi nelle scuole. I bambini e le bambine, fin da piccoli e piccole, possono imparare concetti come il consenso e il rispetto. Ignorare tutto questo, non occupandosene, significa solo una cosa: girare la testa da un’altra parte. Vedo in ogni caso che questa generazione è più preparata su questi argomenti, perché ha maggiore accesso alle informazioni. D’altra parte, c’è il rovescio della medaglia, perché ha accesso anche a messaggi che alimentano la cultura della violenza. La scuola si sta sempre più chiudendo purtroppo, perché non sono previsti percorsi educativi strutturati. Io spesso sono chiamata da singoli insegnanti o dirigenti. Per le ragazze e i ragazzi, poter parlare di questi problemi in uno spazio sicuro, con persone adulte, è importantissimo, anche perché in alcuni casi questi adulti possono diventare essenziali in un percorso di fuoriuscita dalla violenza».
Un altro aspetto problematico è quello della «pornografia del dolore». In questi giorni lei, insieme ad altre trecento persone – giornaliste, attiviste, intellettuali – ha firmato una lettera inviata all’attenzione della Rai contro Nunzia De Girolamo che, nella puntata del 31 ottobre di «Avanti Popolo» con l’intervista alla ragazza vittima della violenza sessuale di gruppo a Palermo la scorsa estate, «ha trasformato la violenza in spettacolo, violando i basilari principi della deontologia professionale».
«Premesso che la ragazza aveva tutto il diritto di decidere se partecipare o meno alla trasmissione, l’impostazione dell’intervista è stata massacrante, in quanto è stata sottoposta a un processo di vittimizzazione secondaria pesantissimo. Non è ammissibile che nel 2023 il servizio pubblico televisivo sottoponga a una violenza così brutale la vittima di una violenza, con tanto di dichiarazioni di alcuni abitanti di Palermo che insinuavano i soliti, orribili stereotipi sulla donna. La risposta di De Girolamo è stata spiazzante (le firmatarie, tra cui esponenti di centri antiviolenza e reti delle donne contro la violenza, sono state accusate dalla coduttrice di “maschilismo latente” e di essere portatrici del “pregiudizio di donne che odiano le donne”, ndr), perché dimostra come non vi sia coscienza di genere. Purtroppo questi sono ancora gli espedienti usati per silenziare una parte di popolazione quando questa fa gruppo e solleva questioni divisive».
Cultura
Da Trento al mondo: le cronache visive di Giorgio Salomon in mostra. Cinquant'anni di storia negli scatti del fotoreporter
di Gabriella Brugnara
L'esposizione, curata da Manuela Baldracchi ed Elena Tonezzer, porta a Palazzo Roccabruna lo sguardo sociale e ironico del fotografo. Dalla città ai grandi scenari internazionali