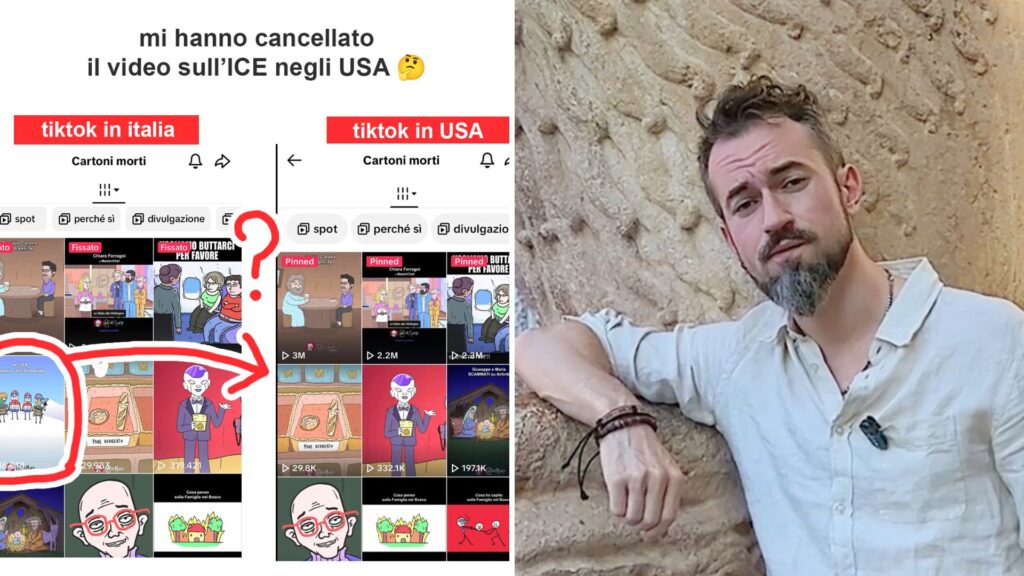Il protagonisa
sabato 20 Gennaio, 2024
Gad Lerner, la Shoah e il ricordo nel presente: «La memoria? È religione civile di democrazia»
di Paolo Morando
Il giornalista e pensatore sarà a Trento, ospite di Living Memory, in occasione della Giornata della Memoria: «Guerra in Palestina, ora tutto è saltato»

Gad Lerner partecipa da anni a iniziative nel Giorno della Memoria. Lo farà anche a Trento, proprio sabato 27 gennaio, alle 20.30 all’auditorium Santa Chiara nell’ambito di «Living Memory» (ingresso gratuito ma serve prenotarsi, sul sito terradelfuocotrentino.org): un monologo intitolato «La memoria scomoda» che, dice, «vorrei che diventasse un dialogo». Ma sarà un Giorno della Memoria diverso dagli altri: «Perché quest’anno sono saltati gli schemi». E vedremo perché.
Come ha affrontato in questi anni il tema della Shoah?
«Lo ho fatto in scuole superiori e medie, ma perfino alle elementari. E cominciavo dicendo: se venisse nella vostra classe una persona che non conoscete e dicesse che i bambini con i capelli rossi devono uscire, come vi comportereste? E così scattavano meccanismi di identificazione, partendo dai quali si poteva ragionare. E non nascondo l’emozione che ho provato ritrovando episodi simili quando assieme a Laura Gnocchi abbiamo raccolto testimonianze di ex partigiani».
Con chi è capitato?
«In particolare con Gastone Malaguti e Luciana Romoli e con i loro racconti di bambini di seconda media e delle elementari, quando nell’autunno 1938 davvero entrò in classe un uomo in orbace per allontanare David e Deborah. Malaguti ricorda di essersi alzato in piedi urlando che non era giusto, David era l’amico con cui andava a nuoto. Gli diedero un calcio nel sedere, lo buttarono fuori e venne sospeso quindici giorni. Cinque anni dopo diventò un gappista, partigiano combattente bolognese: partecipò alla battaglia di Porta Lame».
E Luciana Romoli?
«Anni dopo avrebbe lavorato nella segreteria di Berlinguer, dopo essere stata giovanissima staffetta partigiana a Roma. Lì a entrare in classe fu una donna, disse che Deborah apparteneva a una razza perfida che aveva ucciso Gesù, la prese e la legò per le trecce al cordone della tenda delle finestre. Ci fu una rivolta furibonda, le altre bambine la liberarono e furono tutte punite. Sono episodi poco noti, che precedono di cinque anni l’avvio delle deportazioni, hanno a che fare con il senso istintivo di giustizia dei bambini. Sono convinto che sia connaturato e che venga deformato solo nella formazione culturale».
Con i ragazzi più grandi invece?
«Mi concentravo sulla liceità dei paragoni storici, cioè sulla necessità di “usare” il nostro codice morale derivante dalla memoria della Shoah nel contesto contemporaneo».
Ad esempio parlando dei migranti?
«Sì, ma con tutte le cautele del caso, perché mi rendevo conto che il paragone tra i barconi stipati come carri di bestiame e i treni delle deportazioni poteva risultare persino offensivo. Allora mi sono rivolto a persone come Liliana Segre e Piero Terracina. E sono stati proprio loro a incoraggiarmi e a schierarsi in prima persona».
Oggi invece gli schemi sono saltati. Per quanto sta accadendo in Palestina?
«Sì. La guerra che si sta svolgendo in un fazzoletto di terra intorno alla striscia di Gaza è diventata una guerra mondiale: non solo per l’escalation militare che è arrivata fino al Pakistan e all’oceano Indiano, ma perché ha coinvolto e sollecitato meccanismi di identificazione in miliardi di persone, strattonate a schierarsi con gli uni o con gli altri e a utilizzare quello che gli studiosi chiamano “paradigma vittimario”: cioè il bisogno di individuare chi è vittima principale alla cui sorte aderire, facendo saltare per la grande maggioranza di loro tutti i tabù che, ora ce ne accorgiamo, valevano soltanto in poche parti del mondo».
Cioè la memoria della Shoah.
«Che però, sia chiaro, io continuo a ritenere indispensabile. Sennò non verrei a Trento. È qualcosa a cui dobbiamo rimanere aggrappati. E non lo dico solo per necessità personale».
La sua famiglia venne sterminata.
«Sopravvissero solo i i miei nonni paterni, emigrati in Palestina per far nascere lì mio padre: tutti gli altri furono uccisi. Ma non abbiamo solo bisogno di riprodurre legami personali, bensì l’idea della memoria della Shoah come religione civile dei diritti umani, dell’antirazzismo, della democrazia stessa. Questo però vale solo in una parte dell’Europa e nel Nordamerica. Più a est, già non vale più. Stalin impose la memoria della grande guerra patriottica in cui era proibito distinguere una specifica questione razziale: i morti erano cittadini sovietici, anche quelli di Babi Yar. E non parliamo della Polonia, dove esiste una legge secondo cui le vittime del nazismo furono innanzitutto polacche, proibendo ricerche sul collaborazionismo, mentre a morire furono tre milioni di ebrei polacchi. Mentre in Asia e Africa non vi è alcuna memoria».
Aggrapparsi alla memoria, quindi, oggi che senso ha?
«Può sembrare velleitario farlo, quando si verificano situazioni come Gaza, con decine di migliaia di persone già uccise. Perché si sta diffondendo un’idea velenosa e orribile: quella secondo cui la Shoah è solo un mito inventato per difendere gli interessi di Israele e dell’Occidente. Anche per sentimento di condivisione, ma lacerato ed esitante, mi è capitato di assistere a manifestazioni pro Palestina qui a Milano. E vedendo quei giovani, in maggioranza seconde e terze generazioni di immigrati, è evidente che per loro la memoria della Shoah è qualcosa di vissuto con diffidenza e incredulità. E questo rende diverso il Giorno della Memoria di quest’anno».
E come va allora vissuto?
«Si deve moltiplicare il nostro impegno per consolidare i riferimenti costitutivi della nostra coscienza morale e politica. Cito un intervento di Enzo Traverso: in questa memoria siede la nostra capacità di distinzione tra bene e male, tra difesa e offesa, tra oppresso e oppressore, tra carnefice e vittima. Sono tutti codici che rischiano di venire brutalizzati. Come ha detto Stefano Levi Della Torre, pittore e filosofo oltre che nipote di Carlo Levi, nel Giorno della Memoria dobbiamo studiare, meditare, identificarci nei carnefici e non nelle vittime, per capire come sia stata possibile una desensibilizzazione del comportamento umano che ha portato a rendere normale, senza ripulsa, ciò che è avvenuto ottant’anni fa».
Le sembra che questa desensibilizzazione riguardi oggi anche il cittadino israeliano medio?
«Ne frequento parecchi. Per loro è assolutamente normale che si proceda in un’azione militare che fa nove vittime civili su dieci. Ti dicono: quando è successo a noi nessuno ha mosso un dito, possiamo contare solo su noi stessi. Poi li senti dire che gli arabi sono infidi e che l’unica via è sottometterli. E dall’altra parte sentirai dire: finalmente succede anche agli ebrei di vedersi ammazzati i bambini come succedeva a noi, quelli di Hamas sono partigiani…»
Sembra un punto di non ritorno.
«La questione palestinese non è mai stata considerata una priorità e questo è il risultato: la rimozione. Per cui puoi vivere a Tel Aviv come a Miami Beach ignorando il fatto che Gaza sta a novanta chilometri da lì».