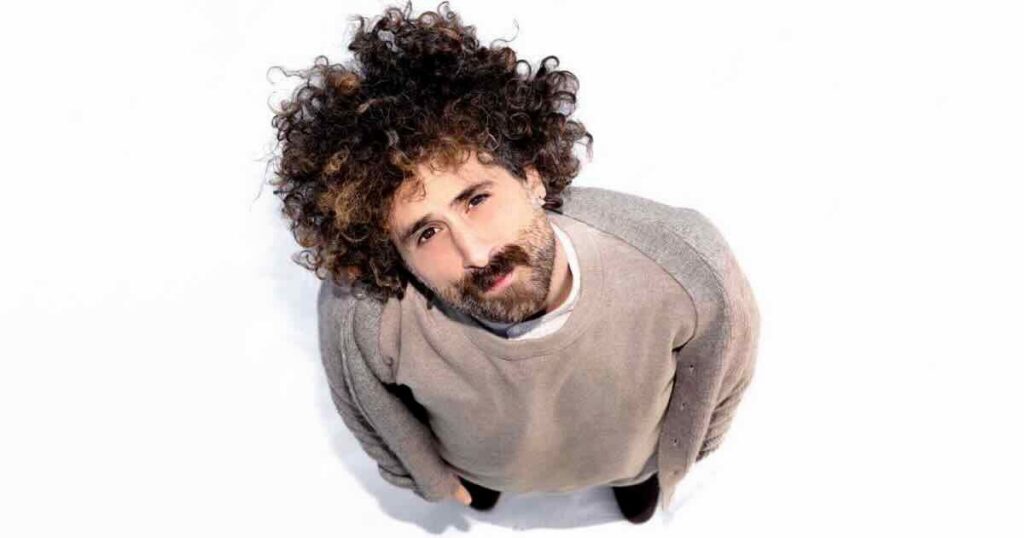L'intervista
mercoledì 9 Aprile, 2025
La filosofa Cavarero: «La maternità è spesso un ostacolo al lavoro, la potenza del generare è valore. Madri surrogate? Un orrore, corpo ridotto a merce»
di Gabriella Brugnara
La docente analizza Le Baccanti, ospite dell'ateneo di Trento: «Propongono un mondo dove regna un’armonia diversa rispetto alla polis maschile»

Riconoscere la potenza generativa femminile non come un ostacolo, ma come una forza vitale e imprescindibile. Riconciliare l’emancipazione con la maternità, una dimensione ancora oggi troppo spesso vista come limitante in un mondo professionale dominato dalle logiche patriarcali. Promuovere un femminismo che non si conformi ai modelli maschili, ma che, al contrario, esprima e valorizzi la pluralità e la specificità dell’esperienza femminile. Accogliere la consapevolezza che, come esseri umani, siamo parte di un tutto, una specie tra le altre, non destinata a dominare. Sono questi alcuni dei temi che Adriana Cavarero esplorerà oggi pomeriggio, mercoledì 9 aprile, alle 18 a Trento (Aula 001, Palazzo Prodi) nell’ambito della conferenza «Euripides’ Bacchae and the defeat of the polis». L’incontro si inserisce nel ciclo «Voices from Contemporary Philosophy», coordinato da Tiziana Faitini, Michele Nicoletti e Alessandro Palazzo, e promosso dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. Giunto alla sua terza edizione, il ciclo continua a offrire l’opportunità di entrare in contatto con alcune delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea. Tra gli ospiti passati si ricordano Charles Taylor, Wendy Brown, Axel Honneth, Lea Ypi e Leela Gandhi. La conferenza sarà introdotta da Lisa Marchi (Trento), con la discussione a cura di Olivia Guaraldo, Giacomo Mormino e Natascia Tosel (Verona). Oltre all’intervento pubblico, il programma prevede anche un dialogo più intimo, che darà a studenti e colleghi l’opportunità di esplorare il pensiero di Cavarero e la sua biografia intellettuale.
Professoressa Cavarero, affronterà «Le Baccanti» di Euripide come una tragedia che mette in scena la «sconfitta della polis». In che modo queste figure femminili incarnano una forza «altra», lontana dalla razionalità politica maschile?
«Le Baccanti racconta la storia di donne di Tebe, appartenenti alla polis, che, secondo l’ordine stabilito, dovrebbero rimanere nel contesto domestico. Tuttavia, possedute da Dioniso, fuggono sul Citerone e vivono esperienze estatiche: danzano, intrecciano corone. Questo passaggio è fondamentale: la natura, in modo gratuito, produce per loro miele, vino, latte, che sgorgano direttamente dalla terra. Le Baccanti si nutrono di questi nettari e, travolte da un’esuberanza alimentare, arrivano addirittura ad allattare cuccioli di lupo. Lo racconto in “Donne che allattano cuccioli di lupo” (Castelvecchi)».
Un titolo che colpisce molto.
«In realtà viene dallo stesso Euripide. Ciò che mi interessa sottolineare è l’opposizione tra due mondi: da una parte, quello della polis, maschile e patriarcale, e dall’altra un mondo alternativo, selvaggio – nel senso positivo del termine – dove regna un’armonia diversa. La terra dona latte e miele, e queste donne, appena diventate madri, allattano cuccioli di animali. È come se umano e animale si confondessero, in un mondo pre-politico».
Perché questo accade?
«Il riferimento esplicito di Euripide è alla cultura arcaica della Grande Madre, che esisteva prima dello sviluppo della polis e della civilizzazione come la conosciamo. Una cultura in cui si è immersi nella natura, non solo nei boschi e nei paesaggi verdi, ma anche tra gli animali. Siamo forme di vita accanto ad altre forme di vita. C’è un accento ecologico molto forte in questo pensiero: comprendere che, in quanto esseri umani, siamo una specie tra le altre, parte di un insieme, e non destinati a dominare. È uno sguardo dall’interno, alla ricerca di armonia, simbolizzato dalle donne che allattano cuccioli di lupo. Anche nel mito fondativo di Roma, la lupa allatta Romolo e Remo».
Crede che esistano Baccanti contemporanee? Movimenti o figure che portano una tensione irriducibile dentro l’ordine simbolico della polis?
«Non credo esista qualcosa di perfettamente assimilabile, ma penso che questa esigenza – il desiderio di rompere con l’ordine simbolico dominante, patriarcale, e di accedere a una forma di relazione alternativa con il mondo – sia molto presente. Si percepisce in vari ambiti, innanzitutto nel pensiero ecologico. Sono assolutamente pro-scienza, anche se la prospettiva scientifica è antropocentrica: si preoccupa principalmente della specie umana. La prospettiva delle Baccanti, invece, rappresenta una costruzione mitica che può affiancarsi alla scienza. È un invito all’umiltà: sentirci come forme di vita tra le altre forme di vita è qualcosa che può rivelarsi di grande aiuto».
«Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa)» (Mondadori), il suo ultimo libro, scritto con Olivia Guaraldo, rivendica innanzitutto il fatto di essere il sesso che genera e la necessità di rappresentare tutto ciò non come un ostacolo, ma come una forza.
«L’emancipazione è un diritto fondamentale, di cui oggi molte di noi godono i frutti. Tuttavia, attenzione all’assimilazione del modello maschile: alla donna, nel mondo del lavoro viene spesso richiesto di comportarsi come se fosse un uomo, di adattarsi a quel modello. In tale contesto, la maternità e il potere generativo diventano un ostacolo: se sei una donna in carriera, probabilmente per te si prospetta una pausa, se hai un lavoro precario, rischi il licenziamento. La mia proposta è che questa potenza del generare – che solo le donne possiedono – non venga vista come un ostacolo, come qualcosa che può disturbare una “perfetta” emancipazione, ma che venga riconosciuta come un valore fondamentale. Torniamo ai cuccioli di lupo: l’aspetto materiale e naturale della generazione deve essere messo in primo piano. La società patriarcale, naturalmente, non ha mai valorizzato tutto ciò».
E dal punto di vista del femminismo?
«Il femminismo della differenza sessuale, di cui sono rappresentante, valorizza profondamente tutto questo, in quanto parte della soggettività femminile libera. La maternità non è un obbligo, naturalmente, ma non deve neppure penalizzare la carriera. Se guardiamo questa scelta dal punto di vista delle Baccanti, è la natura stessa che si rigenera: esistiamo perché siamo generati, e dovremmo essere al primo posto proprio in quanto esseri che generano».
Il titolo «Donna si nasce» riprende un pensiero di Simone de Beauvoir, la cui proposta rispetto a quanto appena discusso, è stata quella di evitare di fare figli. Che ne pensa?
«Non può essere questa la soluzione. Il messaggio dovrebbe essere, semmai, questo: se volete, fate figli – e costruiamo insieme una società in cui il fare figli sia considerato un valore prioritario».
Oggi anche il dato della differenza sessuale fra maschi e femmine è messo in discussione in quanto ritenuto discriminatorio. E nel mondo di lingua inglese si suggerisce di sostituire la parola «donna» con l’espressione «persona con utero».
«Il femminismo della differenza sessuale rifiuta categoricamente questa proposta, che proviene dal mondo trans. È una proposta che cancella la figura della donna, essendo ostile alla soggettività femminile. Pone al centro un individualismo fortissimo, di matrice statunitense, dove ogni persona può scegliere la propria identità. Si nega l’importanza del sesso alla nascita, e si afferma che ognuno possa scegliere di diventare uomo o donna, o di non appartenere a nessun sesso, di essere fluidamente in transito».
Per molti, il femminismo è visto come obsoleto e superato, nonostante gli studi storici dimostrino che è stata l’unica vera rivoluzione del Novecento.
«Il femminismo è oggi più che mai essenziale, soprattutto di fronte al fenomeno dei femminicidi. Da oltre un secolo, si impegna a decifrare la cultura che alimenta la violenza di genere, rendendo possibili strategie di prevenzione e intervento. Per contrastare davvero la violenza sulle donne, non possiamo fare a meno del suo contributo».
Un altro tema rilevante affrontato in “Donna si nasce” è quello della maternità surrogata.
«La maternità surrogata rappresenta un esempio orribile di come il mercato sfrutti il corpo delle donne, riducendolo a merce. Dal punto di vista etico, è uno dei punti più oscuri della contemporaneità: la capacità generativa viene ridotta a un oggetto di scambio, venduto per il beneficio di altri, e non certo per il benessere delle donne coinvolte. È uno scandalo morale, e chi sostiene questa pratica per convenienze personali è semplicemente ipocrita. Si tratta di un esempio lampante dello sfruttamento capitalistico e senza scrupoli del corpo delle donne, soprattutto quelle che si trovano in difficili condizioni economiche».
L'agenda
Pasqua e Pasquetta in musica: dalle note classiche della Haydn a Umberto Tozzi. Ecco i concerti da non perdere
di Jessica Pellegrino
Fino a sabato l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento propone il suo Concerto di Pasqua che vede esibirsi l’orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Elisa Gogou e accompagnata dalla mezzosoprano, Martina Baroni