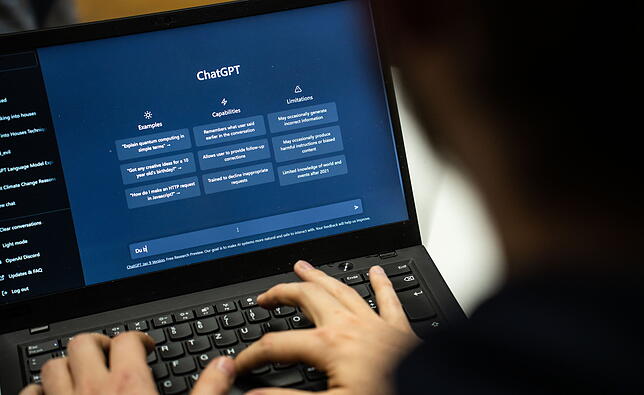la storia
martedì 31 Gennaio, 2023
La storia di un ragazzo transgender raccontata dalla madre: «Ora è se stesso ed è più felice»
di Donatello Baldo
Ha sedici anni, frequenta un liceo trentino e durante la scorsa estate ha trovato il coraggio di confidarsi con mamma e papà: «Può contare su di noi ma la società deve aprirsi di più»

Durante l’intervista la madre non ha sbagliato una volta, il pronome è sempre al maschile: «Lui. Mio figlio», che per sedici anni è stato una bambina. È un ragazzo transgender che ha deciso di ascoltare nel profondo se stesso, accettando di esprimere ciò che sente di essere per davvero. Lo ha comunicato ai genitori, e poi alla scuola.
E com’è andata?
«Ammetto che non eravamo pronti. Un po’ alla volta cerchiamo di capire, di comprendere. Con un obiettivo: accogliere, e impegnarsi fino in fondo perché tutta la società sappia accogliere le persone transgender, le persone come mio figlio».
Racconti dall’inizio, da quando suo figlio ha comunicato alla famiglia il suo sentimento più profondo.
«Manifestava dei dubbi sulla sua identità di genere. E lì per lì gli abbiamo chiesto di darsi tempo, di ascoltarsi senza dare però troppo peso a tutte le domande che emergevano».
Ma l’esigenza di «uscire allo scoperto» era in lui impellente.
«Sì, e stava male. Manifestava piccoli ma importanti disagi che ci hanno fatto preoccupare. Ci siamo quindi rivolti a uno psicologo. Ma non per “curare” la sua identità, non per “normalizzarlo”. Per aiutarlo a stare meglio».
In che senso?
«Il professionista ci chiese, a me e a mio marito, se per noi fosse un problema avere un figlio transgender. Ma il tema non era, e non è quello che lui è, ma come viene accettato dalla società, che non sempre è accogliente».
Il primo posto accogliente dovrebbe essere la famiglia.
«È così. Abbiamo sempre cercato di fargli capire che con noi avrebbe sempre potuto aprirsi, senza mai sentirsi giudicato. Pensi che a un certo punto, dopo il suo percorso in cui ha realizzato di sentirsi un ragazzo transgender, ci ha chiesto se per noi poteva andare bene, se ci avrebbe ferito».
E cosa avete risposto lei e suo marito?
«Che non doveva andare bene a noi. Noi vogliamo che possa realizzarsi come persona».
Da un giorno all’altro, passare dal femminile al maschile. Non è solo questione di nome e pronome, non dev’essere semplice.
«A nostro figlio abbiamo chiesto di avere pazienza, perché non sarebbe stato facile abituarsi. Oltre al confondersi con i pronomi, fino all’anno scorso abbiamo cresciuto una bambina».
Nelle tappe del percorso c’è stato quindi anche quello della scelta del nome, al maschile. Com’è avvenuto questo passaggio particolare?
«Con rispetto ma anche con leggerezza. Lui ha scelto il nome, ce lo ha comunicato. Ma suo padre è intervenuto dicendo che no, le cose non possono andare così».
Così come?
«Sono i genitori che scelgono il nome per un figlio. Lo abbiamo fatto quando è nata, lo dovremmo fare anche ora per la sua nuova identità. Il tutto è stato detto con il sorriso, e abbiamo stabilito di prenderci il tempo di deciderlo durante la vacanza».
Una vacanza che la sua famiglia ricorderà per sempre.
«In quei giorni abbiamo fatto le prove generali, lontano dal Trentino, per essere poi pronti al ritorno alle cose di tutti i giorni, soprattutto della scuola».
Racconti prima della vacanza, della scelta del nome.
«Alla fine si è deciso di convergere sulla sua proposta. E riferirci a lui sempre al maschile».
Settembre è arrivato presto, così la scuola. Il primo banco di prova con la società. E com’è andata?
«Non è stato semplice. Sono stati giorni carichi di angoscia. Stava male, malissimo. L’ansia, il panico, hanno avuto il sopravvento e diceva che l’idea di sentirsi chiamare al femminile gli faceva ribrezzo, che non ce l’avrebbe fatta».
Succede così, che il «dead name», una volta che si è deciso di manifestare la propria identità «elettiva», venga vissuto come una pugnalata ogni volta che viene pronunciato. Suo figlio temeva questa pugnalata?
«Sì, è così. Per lui sentirsi chiamare con il nome anagrafico diventa insopportabile. Come se gli togliessero l’identità».
La scuola lo aspettava sui banchi. Cosa avete deciso di fare?
«Ricorderò per sempre la notte prima dell’inizio delle lezioni. Lui si era chiuso in bagno, non usciva, era dentro che piangeva a dirotto».
E lei?
«Io fuori, seduta contro la porta, che piangevo anch’io. Io e lui, senza sapere cosa poter fare. Non sapevo come proteggere e difendere mio figlio. Non avevo soluzioni, e passavo le ore andando a cercare su Google le risposte, che però non c’erano».
La scuola a quel punto poteva aspettare.
«E infatti ha iniziato la scuola un mese dopo. Ci siamo presi il tempo per affrontare la cosa a 360 gradi. Abbiamo avuto un grande aiuto dallo psicoterapeuta che ha iniziato a interloquire con la scuola, con la vicepreside che ha convocato appositamente il consiglio di classe per affrontare la questione».
Come hanno reagito gli insegnanti?
«Devo ammettere che la loro disponibilità è stata massima. Non credevamo nemmeno che potessero manifestare una tale apertura, tutti si sono dimostrati ben disposti».
Tra i docenti nessuno ha manifestato il minimo disagio o imbarazzo?
«No, davvero. Tutti hanno capito e condiviso l’importanza di usare il suo nome d’elezione per rivolgersi a lui».
Tutto bene, dunque.
«No. Perché la buona volontà dei docenti di ruolo non è sufficiente. Sul registro c’è il nome anagrafico, al femminile. Quando arriva una supplente succede, ed è già successo due volte, che si rivolga a mio figlio come fosse una ragazza, creando in lui un grave e profondo disagio. Ci siamo informati, sappiamo che sarebbe possibile avviare quella che viene definita “carriera alias”, con la modifica del nome sul registro, ufficialmente. Ma i dirigenti scolastici dicono che non è così semplice».
Non è semplice sconfiggere la burocrazia o il pregiudizio politico verso la carriera alias?
«Non so. Ma è notizia di questi giorni che la dirigente si è informata, e anche qui in Trentino sarebbe possibile. Ma la stessa dirigente ci ha riferito che preferirebbe confrontarsi con altri suoi colleghi di altri istituti dove si è posto lo stesso problema per la presenza di altri studenti transgender, ponendo così il tema a livello provinciale».
A proposito, sa che un consigliere provinciale ha depositato un disegno di legge per contrastare ogni riferimento al cambio di genere nelle scuole e che una petizione di ProVita con lo stesso intento è stata presentata al Consiglio provinciale? La loro tesi è che tutto questo sia una moda. Cosa ne pensa?
«Penso che questi politici non hanno visto la grave e devastante sofferenza di mio figlio. Il male che ha vissuto, la sua paura. Chiunque, nei panni di nostro figlio, avrebbe smesso subito quel percorso di dolore se si fosse trattato di una moda. Mio figlio ha avuto il coraggio di guardarsi dentro, di accettarsi. Ha attraversato sentimenti contrastanti per trovare se stesso e la sua vera identità. A volte lo guardo e gli dico quanto sia stato forte. Sono fiera di lui: è riuscito a sopravvivere a tutto questo».
Il percorso è ancora lungo. Ora ha solo sedici anni, poi ci sarà l’università, il lavoro. È preoccupata?
«Ci saranno altre sfide da affrontare, ma ce la faremo. Quello che facciamo noi, speriamo che possa servire in futuro per rendere la vita più facile ai tanti che verranno dopo. In fondo è anche una lotta per costruire una società migliore e più accogliente».
Tutto sommato questa è una bella storia. Nonostante la sofferenza siete riusciti a fare squadra, anche come famiglia. È felice?
«Sì, sono felice che mio figlio possa avere la possibilità di essere se stesso. E a volte penso che in fondo siamo stati fortunati».
Cosa vuol dire?
«Che abbiamo trovato un bravo psicoterapeuta che ha seguito il percorso di nostro figlio con attenzione, che gli insegnanti hanno mostrato grande professionalità, che con i compagni di classe non ci sono stati problemi. Manca solo quel tassello burocratico del cambio del nome sui documenti, che sembra una piccola cosa, ma per una persona transgender è fondamentale. Per il resto abbiamo scoperto che se c’è amore c’è comprensione, sempre».
Nella famiglia allargata, nonni e zii e amici, lo sanno tutti?
«Tutti, anche il nonno. A mio padre ho spiegato tutto per filo e per segno, cercando di usare parole semplici ma senza nascondere nulla. Ha ascoltato senza dire una parola, poi mi ha chiesto: “Lui sta bene?”. Ha usato il pronome giusto, al maschile, e si è informato subito di come stesse suo nipote. Le due cose più importati in una frase sola. E se è stato capace di accoglienza e amore lui, a oltre ottant’anni, dovremmo esserne capaci tutti».