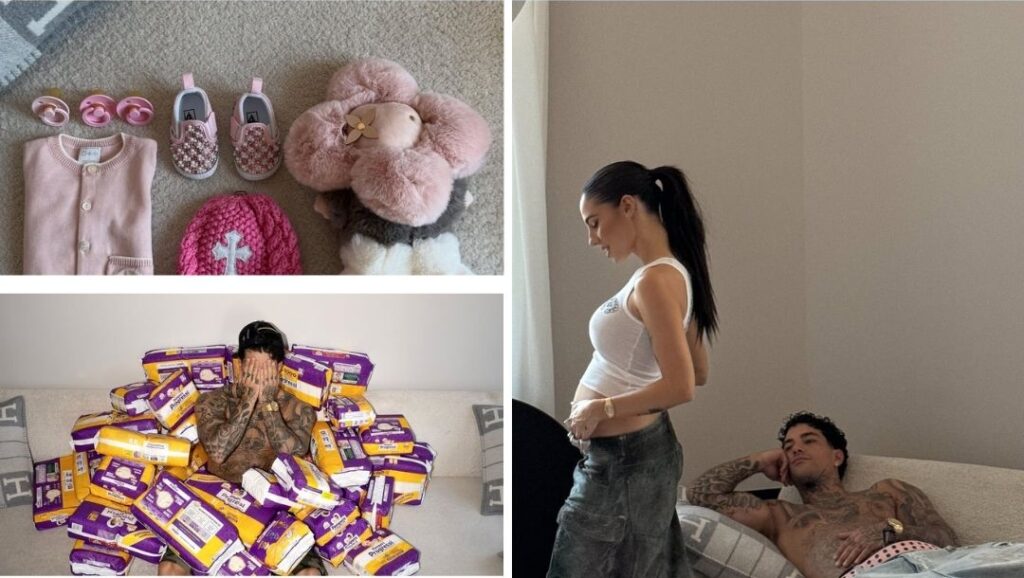L'intervista
giovedì 18 Maggio, 2023
Mariapia Veladiano, nuovo romanzo: «Raccolgo storie di persone ferite che vogliono vivere»
di Riccardo Mazzeo
«Quel che ci tiene vivi» è uscito da pochi giorni. L'insegnante, dirigente scolastica anche in Trentino, racconta il suo rapporto con la scrittura e con la scuola

Mariapia Veladiano, vicentina, laureata in filosofia e teologia, insegnante, dirigente scolastica anche in Trentino, è una romanziera famosa in Italia e all’estero. Il suo primo romanzo, La vita accanto, dal quale il regista Marco Tullio Giordana ha tratto il soggetto per il suo ultimo film attualmente in lavorazione, dodici anni fa ha vinto il Premio Calvino ed è arrivato secondo al Premio Strega. Poi ne ha scritti molti altri, tutti connotati da quegli elementi personologici e poetici che latitano in modo bruciante e avvilente nel nostro tempo: la capacità di ascolto, la disponibilità a sintonizzarsi, il culto di una bellezza autentica e specifica contrapposta al glamour e alla banalizzazione tribale e volatile, la profondità e uno sguardo capace di coltivare sempre la speranza e la riparazione possibile delle cose della nostra vita.
Mariapia Veladiano, lei è diventata famosissima con il suo primo romanzo «La vita accanto»: duecentomila copie vendute, tradotto in un’infinità di Paesi… L’avevo letto e mi era piaciuto, ma il mio interesse per lei nacque quando lessi il suo secondo romanzo, «Il tempo è un Dio breve»: per me, agnostico, la storia di questa donna cattolica che crede suo figlio sia destinato a morire e intraprende un violentissimo faccia-a-faccia con Dio è stata sconvolgente: non avevo più pensato a Dio da quando avevo dieci anni…
«Perché il male del mondo? È l’unico tema serio per chi crede in un Dio che ama la vita. Ci sono biblioteche di trattati teologici che cercano una risposta e spesso è stata una risposta indecente, che non tiene conto davvero del dolore di chi perde un bambino, un affetto. I romanzi possono di più. C’è più teologia nei romanzi che in tanti trattati perché la teologia ha sempre un poco la pretesa di chiudere il cerchio della domanda, di dare una risposta coerente con la dottrina, mentre il romanzo può rispettare il mistero di una vita che è colpita, si interroga, si dà sì risposte, ma piccole risposte senza pretese di universalità, che però permettono comunque di continuare a sperare. “Il tempo è un Dio breve” ha provato questa strada. Ildegarda madre colta, libera, interrogante, si dà una risposta che passa attraverso il corpo e che però rimane sospesa fino alla fine. Non chiude il cerchio. Non è una verità da credere o da condannare. Vuol dire prendere sul serio il mistero».
Lei ha insegnato per trent’anni ed è stata dirigente scolastica anche in Trentino. Ha descritto il mondo dei piccoli in un saggio, per la verità molto poetico, «Parole di scuola», che riesce a far focalizzare il lettore sugli aspetti che spesso passano sottotraccia perché si trovano in piena luce con la loro superficie e occultano il mondo di tensioni, sofferenze, ambivalenze che c’è sotto e che dovremmo imparare a tenere presente.
«Lavorare nella scuola è un privilegio. Si è dentro a una grande esperienza di comunità che può meravigliosamente funzionare. E se funziona i ragazzi e le ragazze escono con la bella sicurezza di poter abitare lo stesso mondo senza che sia una giungla in cui si sopravvive solo affilando gli artigli. Perché la scuola, pubblica, riceve il mondo senza selezionarlo e quando trova il modo di non lasciare indietro nessuno, diminuire le disuguaglianze, attivare attitudini collaborative, allora l’eccellenza tanto divisiva è solo il nome vero di una qualità diffusa, che interessa tutti i ragazzi. Ma è un lavoro. Bisogna andare controvento, è una parola che uso da sempre, perché oggi la scuola è terreno di scontro, è strumento di privilegio, è il raccoglitore delle nostre paure di adulti che vedono il futuro dei figli sotto il segno della precarietà. I ragazzi sono avvolti di paura invece che di fiducia. È durissimo per loro vivere così, ma gli adulti siamo noi e bisogna essere consapevoli e cambiare».
Il suo ultimo romanzo appena uscito, «Quel che ci tiene vivi» (Guanda, 2023), l’ho trovato prezioso e mi ha fatto ripensare a «Libertà» di Franzen, un romanzo che mentre si legge induce insofferenza, rabbia, addirittura odio per alcuni personaggi ma che poi, una volta finito, quei personaggi ce li fa sentire familiari, degni perlomeno di comprensione. I suoi personaggi invece, in realtà, ci parlano della possibilità di sopravvivere ai traumi trovando la forza e la propensione ad «aggiustare» per quel che si può il nostro mondo…
«Raccolgo storie di persone ferite che però vogliono vivere, come tutti. Qui c’è un giovane avvocato sgarrupato che mangia troppo, beve troppo, rifiuta i clienti. Ma c’è il perché e non sempre il perché è, come dire, rimediabile. La sua famiglia sciagurata non ha rimedio, e allora ecco, nei romanzi vado a spigolare aggiustamenti possibili, riparazioni. Si impara con i bambini, questo. Cioè che sempre i comportamenti per quanto estremi hanno una ragione d’essere e che molto spesso si può operare qualche riparazione. Sono questi i miei romanzi, fin dal primo, la storia di Rebecca bambina brutta. In “Quel che ci tiene vivi” lui non diventa ottimista e virtuoso, però impara l’arte di salvare il bambino che una notte si trova davanti, che non vuole davvero vedere, che cerca di evitare. Eppure. Non è questione di ottimismo. È che i romanzi cercano di offrire uno sguardo non scontato sulla realtà. Creare un percorso emotivo che possiamo riconoscere vero anche se non ci abbiamo mai pensato. Qui c’è come sempre il grande tema della famiglia. Che cosa è davvero famiglia? Naturalmente c’è una donna, Bianca, psicoanalista che bizzarramente si innamora di lui e deve imparare a camminare sul filo teso fra il suo lavoro di cura e l’amore. E poi c’è la provincia, che fa finta di non vedere eppure sa tutto quello che accade. È sempre così. Quando capita qualcosa di tremendo c’è uno che fa e ci sono dieci che non vedono. In un mondo omissivo, quel che conta è imparare a vedere, sempre. E nel romanzo gioco ancora una volta il tema dell’essere visti per salvarsi, del vedere per salvare».
L'intervista
Don Ciotti: «Papa Francesco è tornato alla radicalità della Parola. Dopo di lui? Spero in un messaggio di continuità e in una Chiesa per i poveri»
di Marika Damaggio
Il fondatore di Libera a Trento. «La mafia è oggi “presentabile”, col volto di un attore economico fra gli altri. Accanto ai suoi traffici di morte – droga, armi, rifiuti tossici – che fruttano parecchio,
si muove con disinvoltura»
i premi
Trento Film Festival, «Donde los árboles dan carne» di Alexis Franco vince la Genziana d’oro come miglior film
di Redazione
Il regista argentino descrive la resistenza solitaria e tenace di un gaucho argentino e della sua famiglia contro la siccità e la crisi climatica. Ecco tutte le pellicole premiate
cultura
International Alliance for Mountain Film, confermato il Presidente uscente Jabi Barayazarra
di Redazione (Foto di Cristian Baldessari)
Domani, in occasione del Gala di premiazione dei vincitori delle Genziane, sarà consegnato il Gran Premio dell’Iamf al regista francese Sébastien Montaz-Rosset