Il personaggio
lunedì 31 Marzo, 2025
Paolo Mirandola, il decano degli avvocati roveretani: «Macché politicizzazione, la giustizia è in crisi per mancanza di meritocrazia»
di Anna Maria Eccli
Togato da 47 anni, l'impegno politico e l'insulto a Salvini. «Una passione di famiglia: mio zio a 15 anni portava in giro il palco da cui Cesare Battisti arringava la folla»
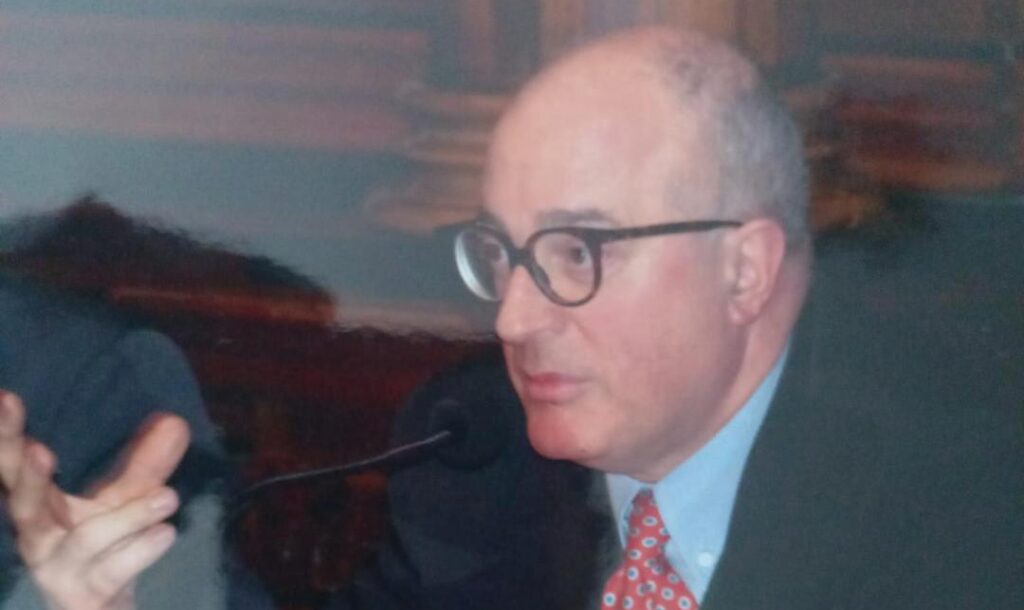
Quarantasette anni di toga, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto dal 2004 al 2007, consigliere comunale per il Partito Democratico, consigliere del Centro per la Cooperazione Internazionale dal 2018: ma l’avvocato Paolo Mirandola deve avere anche qualche ascendenza genica in comune con il celebre Pico, visto come snocciola date, nomi, località, senza ripensamenti, senza vacillare. Classe 1945, attivo in molte realtà culturali (Fondazione Campana, Associazione Italia-Austria, Accademia degli Agiati…), da presidente nazionale della Federavvocati, carica che ha ricoperto per due volte, nel 1994 ha ricevuto attestazione di stima dal Presidente della Repubblica Scalfaro.
È merito anche suo se a metà del Ponte Forbato, in Santa Maria, come pietra d’inciampo c’è la targa che ricorda l’intellettuale cecoslovacco Bohumir Klipa, dirigente di Charta ’77.
Nella sua lunga vita professionale ha avvicinato magistrati come Luciano Violante, Mino Martinazzoli, Mauro Mellini, in quella culturale ha fatto parte della bella stagione di Cultura Viva, nata grazie al magistrato Antonio Grassi. Lingua tagliente, una decina di anni fa ha dovuto risarcire Matteo Salvini per un giudizio offensivo pronunciato in Consiglio Comunale e, da spirito libero, nel 2023 si espresse a favore della riforma della giustizia, in particolare per l’abolizione del reato di abuso d’ufficio inutile appesantimento amministrativo.
«Il diritto non può essere soltanto diligente pratica, procedura, tecnica; in esso si intersecano storia, filosofia, letteratura, poesia. Non si può rendere giustizia se non facendo i conti con questi saperi umanistici perché delineano un orizzonte che fa la differenza nel modo di affrontare le cose, il mondo, gli uomini, l’arte, la giustizia», dice. A suo tempo sostenne la bozza di riforma elaborata da Marco Boato, discussa e approvata nel 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ma duramente osteggiata dall’establishment della Magistratura dell’epoca.
Avvocato, di dove sono originari i Mirandola?
«Della bassa veronese; nonno Domenico era migrato a fine ‘800 da Isola della Scala. Carpentiere a Rovereto, sposò nonna che scendeva dalla Val Badia. Tra Via Mazzini e Via Garibaldi c’era un luogo, chiamato “la badia”, abitato prevalentemente da artigiani provenienti da quelle parti e dalla Valsugana. Ebbero 7 figli. Nel 1908 su incarico dall’impero asburgico nonno andò a Messina per coordinare i lavori d’aiuto alla popolazione: il 28 dicembre di quell’anno c’era stato lo storico sisma che in 37 secondi sterminò mezza popolazione. Rimase lì 2 anni. Era giovane, ma quando tornò morì d’infarto nell’arco di due mesi. Allo scoppio della Grande Guerra nonna e i suoi figli dovettero evacuare in Austria superiore, vicino a Linz. Un ricordo di famiglia è quello di zio Giovanni, socialista, che a 15 anni trascinava per le vie di Rovereto il carro con sopra il palco dal quale Cesare Battisti faceva i suoi comizi; allo scoppio della guerra fuggì, arruolandosi nell’esercito italiano. Fatto prigioniero e deportato in un campo fuggì anche da lì finendo in Boemia. Fu salvato da un pastore protestante con il quale mantenne i contatti fino alla fine. Negli Anni ’60 fu consigliere comunale per il Psi».
Lei ha studiato Giurisprudenza a Padova città «nera» all’epoca.
«Sì, un giorno scoppiò una bomba nella biblioteca di Filosofia del Diritto in cui, poche ore prima, stavo studiando. Ma ho avuto insegnanti eccezionali che hanno segnato la mia vita culturale e professionale; Ettore Gallo, grande giurista di Diritto Penale, ex comandante partigiano, Enrico Opocher, che insegnava Filosofia del Diritto, pure lui ex dirigente partigiano e Lorenza Carlassare, docente di diritto costituzionale con la quale mi sono laureato su “Il principio del giudice naturale precostituito per legge”, articolo 25 della Costituzione. La traccia me l’aveva suggerita l’avvocato Sandro Canestrini, anche lui mio maestro, rappresentante della migliore avvocatura del tempo».
Perché il sistema Giustizia in Italia è in crisi?
Partiamo dal concetto che la Giustizia è una questione primaria per ogni Stato costituzionale. I suoi presupposti sono nella Costituzione nata dalla Resistenza, che avrebbero dovuto permeare la cultura e la formazione professionale di avvocati e magistrati. Così non è stato.
Sta dicendo una cosa molto grave.
«Ma è così; gran parte della magistratura nel ’48 proveniva dai ranghi dal regime. Era formata da chi andava ad applaudire Mussolini nella sala del Mappamondo, a Palazzo Venezia. All’inaugurazione del primo anno giudiziario post Ventennio, a Costituzione promulgata, il Procuratore Generale della Cassazione non menzionò nemmeno il fatto che fosse nata la Repubblica. Voglio dire che, sostanzialmente, ci fu continuità col passato. Lo stesso Palmiro Togliatti, primo ministro della Giustizia del dopoguerra, ebbe come capo di gabinetto un certo Gaetano Azzariti, ispiratore e redattore delle leggi razziali nonché Presidente del tribunale sulla razza. Sempre Azzariti negli Anni ’60 fu nominato consigliere della Corte costituzionale da Gronchi e un certo Oggioni, già Procuratore Generale della Repubblica di Salò, fu nominato giudice costituzionale da Saragat. Arriviamo agli anni ’80 con una Magistratura formatasi nel periodo fascista, ostile alla carta costituzionale».
Come è sopravvissuto?
«Lottando, come mi aveva insegnato Canestrini, credendo nel “servizio giustizia”. Per fortuna girando l’Italia ho potuto conoscere il meglio, quella parte minoritaria di magistratura e avvocatura da cui nel ’64 nacquero la corrente di Magistratura Democratica e il sindacato degli avvocati.
L’uomo comune potrà ignorare qualcosa, ma interpreta benissimo la supponenza, la difformità rispetto al concetto di “servizio”, di moltissimi magistrati e di altrettanti avvocati.
Sono due categorie legate a vecchie ritualità, chiuse a casta. Nel maggio ’68 a Padova per la prima volta si levò la voce dissonante di un padre costituzionalista, Piero Calamandrei, in un numero speciale della rivista “Il Ponte”. Un altro grande maestro fu Federico Governatori, direttore della rivista “Quale giustizia?”, una bussola per me. Ma ancora nel ’75, al Congresso nazionale forense tenutosi a Gardone, si osannava l’avvocato De Marsico, ministro fascista della Giustizia. Non posso dimenticare che il fascismo ha consegnato agli assassini gli avvocati Angelo Bettini, Duccio Galimberti, giganti della Resistenza… Ancora oggi l’inaugurazione dell’anno giudiziario avviene con un rito stantio, tra paludamenti rossi, trombe, ermellini, espressioni di massima lontananza del Servizio Giustizia dovuto ai cittadini».
L’accusa di politicizzazione della Magistratura?
«È di per sé una sciocchezza. Ogni magistrato è portatore di propria cultura, proprie aspettative, proprio modo di pensare. Questo non dovrà incidere sulla formazione del convincimento, da cui scaturirà ogni decisione».
Avvocato, cos’è “La toga e il tarlo”?
«Una scultura in legno e cartone verniciati, di Fortunato Depero. Quando la vidi chiesi di poterla riprodurre sul manifesto di un convegno che stavo organizzando e da perfetta sconosciuta nel 1986 è entrata negli studi degli avvocati di tutt’Italia. Poi ne facemmo un logo ufficiale dell’Ordine degli avvocati di Rovereto; è uno dei più belli d’Italia».
l'intervista
Celina Murga e il suo film sull'Argentina: «Racconto le fragilità di un Paese in crisi»
di Michele Bellio
La regista e sceneggiatrice argentina sarà al Festival trentino come giurata e con la sua pellicola «Destinazione… Argentina». «Martin Scorsese? Un amico e collega. Il suo supporto è fondamentale»



















